Breve storia dell'aeromodellismo in Italia 
Dall'articolo "Piccole Ali" - Annuario AeCI 1993, Pag. 11 e succ.
L'aspirazione al volo è stata certamente per molti secoli una delle più forti, e nello stesso tempo più utopistiche, degli uomini che, fin dagli albori della vita sulla terra, videro gli uccelli librarsi maestosamente nel cielo, e sognarono di poterli imitare. Ma molto e molto tempo dovette trascorrere prima che tale aspirazione potesse tradursi in realtà.
Infatti anche se nelle antiche cronache troviamo riferimenti a macchine volanti che sarebbero state realizzate con risultati più o meno brillanti, come la famosa "colomba volante" di Archita, filosofo pitagorico del IV sec. A.C., dobbiamo ritenere che tali realizzazioni appartengano più alla leggenda che alla realtà. Per trovare i primi seri studi sulla possibilità del volo, studi che sono arrivati a noi nella loro integrale genialità, dobbiamo arrivare a Leonardo da Vinci, la cui incommensurabile mente concepì le prime macchine volanti, anche se la tecnica dell'epoca non gli seppe fornire i mezzi necessari per realizzarle. E' infatti solo nel XIX sec., con il grande impulso conferito alla tecnica dalla diffusione delle macchine, che cominciò a svilupparsi la coscienza aeronautica, per opera di pochi tenaci appassionati, dapprima considerati con derisione, e quindi con rispetto ed ammirazione via via crescenti.
Il precursore dell'aviazione
Nacque allora l'aeromodellismo, che, in un certo senso, è stato il precursore dell'aviazione, per poi progredire parallelamente ad essa, ed infine svilupparsi come disciplina e sport indipendenti. Infatti i primi studiosi ed appassionati di aviazione, prima di costruire un vero aereo ed affidare alle sue fragili ali le loro speranze e la loro vita, realizzarono spesso dei piccoli modelli, con i quali collaudare praticamente le loro teorie; come del resto si fa oggi, sebbene in proporzioni assai maggiori, nel campo dell'astronautica. Il primo modello volante di cui si abbia veramente cognizione, venne realizzato nel 1843 dall'inglese Henson, e quindi perfezionato dal suo collaboratore Stringfellow. Tale modello misurava 3 m. di apertura, pesava 4 Kg, ed era dotato di due eliche azionate da un motore a vapore, che gli permisero di fare alcuni balzi di una ventina di metri.
Come primo vero e proprio modello volante viene però generalmente considerato il "planoforo", realizzato nel 1870 dal francese Penaud, che, non disponendo di un motore a scoppio, pensò per primo di utilizzare la torsione di una matassa elastica. Il suo modello, assai semplice e razionale, riuscì ad effettuare dei voli di 60 m. in 13 secondi, e venne seguito da diversi altri, dalle forme più disparate. Seguirono numerosi altri modelli, fra cui, da segnalare, il biplano del tedesco Otto Lilienthal, che fu poi il primo uomo a volare con un aereo veleggiatore, e finì per immolarsi alla causa del volo. Furono sperimantati modelli ad ali battenti, idro, ecc., in Francia, Inghilterra ed America, mentre apparivano i primi motori ad aria compressa e ad anidride carbonica.
Quindi, mentre Wright compiva il primo volo con un aereo a motore, e l'aviazione iniziava la sua ascesa trionfale, l'aeromodellismo cominciava a svilupparsi come attività autonoma, sia pure inizialmente legata alle ricerche aeronautiche; ed anche i giovani si dedicavano alla costruzione di modelli volanti. Nel 1905 ebbe luogo a Parigi la prima gara aeromodellistica, organizzata dalla Commissione per l'Aviazione dell'Aero Club di Francia, che venne vinta da Peyret con un modello veleggiatore che, lanciato da un pilone alto 41 metri, raggiunse la distanza di 131 m. in 18 secondi.
Seguirono altre gare in Francia ed in Inghilterra, e finalmente, nel 1911, ebbe luogo il primo concorso aeromodellistico italiano, organizzato a Roma dalla rivista "Aria e Moto" in cui furono presentati modelli dalle forme più disparate.
La strada definitiva
Dopa una forzata parentesi dovuta alla guerra ed alle vicende del dopoguerra, l'aeromodellismo italiano riprese il suo sviluppo. Nel frattempo la prima guerra mondiale aveva dato un poderoso impulso all'aviazione ed alle ricerche aerodinamiche, grazie alle quali anche l'aeromodellismo aveva ormai trovato la sua strada definitiva. Infatti nelle prime ricerche sperimentali gli uomini erano stati naturalmente portati ad imitare il volo degli uccelli, ed a realizzare dei modelli ad ali battenti; ma ormai si era compreso che, non essendo possibile realizzare in pratica la flessibilità, la variabilità del profilo e l'armonia dei movimenti delle ali degli uccelli, era molto più conveniente ricorrere all'ala rigida, usando come propulsore l'elica. Infatti su questo schema si basarono tutte le costruzioni del XX secolo, mentre gli ornitotteri venivano relegati al campo sperimentale. Per quanto riguarda la forma di energia, Penaud aveva chiaramente indicato la strada più semplice: la gomma elastica che permette di immagazzinare una sensibile quantità di energia, che può essere sfruttata con la massima semplicità. Naturalmete, fin da allora, forte era il richiamo del motore meccanico; ma in mancanza di efficienti piccoli motori a scoppio, per la realizzazione dei quali dovevano trascorrere ancora diversi anni, si ricorse momentaneamente al motore ad aria compressa, che era costituito da tre o quattro cilindri, nei quali veniva fatta circolare l'aria compressa contenuta in un serbatoio, generalmente costituito dalla stessa fusoliera, realizzata in lamierino di ottone, che prima di ogni volo veniva riempita con aria compressa mediante una pompa da automobile. Però, a parte la scarsa praticità ed il pericolo di esplosione dei serbatoi, i motori ad aria compressa offrirono sempre un rendimento assai basso, inferiore a quello della matassa elastica; per cui scomparvero dalla scena non appena apparvero i primi modelli a scoppio. Fra i modelli ad elastico si diffuse molto, in quel periodo, lo schema "canard" cioè quel tipo di modello che ha il piano di coda sistemato anteriormente all'ala; mentre la matassa veniva generalemente sistemata all'interno di un tubo di impellicciatura. Assai diffuso anche lo schema con doppio tubo, e quindi due matasse con relative eliche.

Anni 30: un modello ad elastico con configurazione "canard". La fusoliera a doppio tubo contiene due matasse, collegate a due eliche propulsive.
Le prime gare
Per quanto riguarda le gare aeromodellistiche del dopoguerra, da ricordare un concorso organizzato nel 1922 sull'aeroporto di Taliedo (Milano) dall'Istituto Nazionale di Propaganda Aeronautica, concorso che venne vinto con un volo di 176 m. (le gare di allora si basano sulla distanza, anziché sulla durata). Nel 1925 lo stesso ente organizzò il secondo concorso, che non fornì grandi risultati di distanza, mentre permise di stabilire il record italiano di durata, con 51".
L'anno successivo ebbe luogo a Roma la prima esibizione della Coppa Bommartini, messa in palio dal noto appassionato di aviazione conte Bommartini, gara che doveva giocare un notevole ruolo nello sviluppo dell'aeromodellismo italiano, dato che viene effettuata ancora oggi.
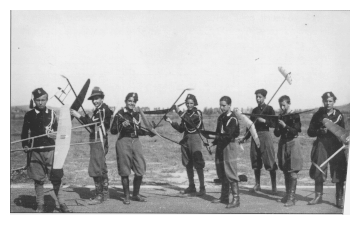
Anni 30: giovani fascisti con i loro modelli ripresi in occasione di una gara.
Tale competizione venne inizialmente riservata agli studenti delle scuole medie, e non poté logicamente raccogliere grandi risultati.
Nel 1927 e 28, altre importanti gare si svolsero a Milano e a Torino, dove l'Aerocentro "Gino Lisa" dava grande impulso allo sviluppo dell'aeromodellismo. Infatti nel corso di una gara torinese venne effettuato un nuovo volo record con 415 m. di distanza, e 62 secondi di durata. Sempre nel 1928 e nell'anno successivo, veniva effettuata a Bologna la "Coppa Littorale"; mentre verso la fine del 1929 aveva luogo a Roma la prima gara nazionale per la disputa della Coppa Bommartini e del Premio del Littorio, cui parteciparono oltre 60 concorrenti, selezionati in numerose eliminatorie provinciali, ed interamente spesati dal Reale Aero Club d'Italia. I risultati tecnici furono ottimi, perché la coppa Bommartini, sempre riservata agli studenti, venne vinta con un volo di 302 m.; mentre il vincitore del Premio del Littorio, con un modello a due eliche controrotanti, percorse una distanza di 900 m., stabilendo il nuovo record mondiale per modelli ad elastico.
Tale gara venne ripetuta con buoni risultati nel 1930, mentre andava sempre aumentando l'attività aeromodellistica, con le sezioni che si andavano costituendo nelle principali città italiane.
"L'Aquilone"
Nel 1931, a Torino, iniziava le pubblicazioni "L'Aquilone", rivista di propaganda aeronautica che dedicava alcune pagine all'aeromodellismo. Tale rivista conduceva vita stentata e sarebbe morta se il capo dell'Ufficio Stampa del Ministero Aeronautica, Ten.Col. Ugo Rampelli (oggi Gen. Sq. Aerea in p.a.) non ne avesse intuita l'utilità ai fini della propaganda fra i giovani e per la diffusione dell'aeromodellismo. L'Aquilone si trasferì a Roma e, compilato in seno all'Ufficio Stampa dell'Aeronautica, raccolse nelle sue pagine numerosi articoli tecnici e propagandistici, ad opera di appassionati i cui nomi o pseudonimi divennero ben presto un simbolo per gli aeromodellisti italiani: Ugo Rampelli, già nominato, "Zio Falcone" cioè il Direttore de L'Aquilone Gastone Martini; l'"Ing. B", cioè l'Ing. Giorgio Bacchelli, apprezzatissimo studioso dei problemi teorici ed ineguagliabile delegato nazionale per l'aeromodellismo, purtroppo scomparso nella Campagna di Russia; "Giarella", ossia il bolognese Paolo Nobili, che curò per molti anni i corsi di aeromodellismo e la corrispondenza tecnica con i lettori; quindi "Crivello 1" e "Crivello 2", cioè i fratelli Mario ed Alberto Guerri, autori di divertenti cronache e spiritose corrispondenze; il pittore Alberto Mastrojanni, autore delle spiritosissime copertina a colori; e quindi Travagli, Tione e tanti altri.
Nel suo primo anno di vita, "L'Aquilone" organizzò una gara aeromodellistica riservata agli studenti delle classi elementari e medie, che fu vinta rispettivamente da Mario Cotto e Aldo Capoletti, ambedue con modelli ad elastico del tipo a tubo. Nello stesso anno vennero effettuate due gare a Venezia e a Pordenone; ed in quest'ultima vennero ottenuti notevoli risultati, con la vittoria di Luciano Cattaneo con un volo di 1'40", ed il secondo posto, con 1'37", di Libero Biasin, uno dei più tenaci assertori del modello "Canard".

Nel 1932 la gara nazionale ebbe luogo sempre a Roma, all'aeroporto del Littorio (l'attuale Urbe) dopo numerose eliminatorie regionali, e consisté in una prova di velocità su una base di 150 m., che venne coperta dal vincitore, il romano Fortunato Selvi, alla media di 52,250 Km/h con un modello Canard bitubo; mentre un premio speciale veniva attribuito al concorrente Roberto fedeli, per l'interessante concezione del suo modello, munito di due matasse del peso complessivo di 200 g. con rinvio ad ingranaggi. Fra i partecipanti a questa gara da notare i nomi di: Pelegi, Cadueri e Papalia, che ritroveremo nelle cronache successive.
Un volo sensazionale
Anche nel 1933 la gara nazionale si svolse a Roma ,dopo le eliminatorie provinciali, come ormai stabilito dalla Reale Unione Nazionale Aeronautica (R.U.N.A.). Oltre alla gara di velocità, che venne vinta dal bolognese Rino Giordani con 56 Km/h, seguito dal vincitore dell'anno precedente Selvi, ebbe luogo per la prima volta una gara del tipo che doveva poi divenire classico, cioè una gara di durata, sempre per modelli ad elastico, gara che vide la strepitosa vittoria di Giorgio Carlesso, di Pordenone, con un volo che, per quei tempi, costituì veramente un primato.
Infatti il suo modello, un canard monotubo di grandi dimensioni, pesante in ordine di volo solo 250 g., veleggiò per 45 minuti, raggiungendo una quota di 1000 m. E' facile immaginare l'entusiasmo che suscitò tale volo, e gli onori che raccolse il costruttore del modello. In questa gara si affacciarono alla ribalta altri nomi destinati a raggiungere la notorietà: D'Arbesio, Tedeschi, Ciampolini, Barthel ed altri.
I primi motori
L'anno successivo portò due importanti novità. Infatti, oltre alla gara di durata per modelli ad elastico, questa volta suddivisi nelle categorie Junior e Senior, vinte rispettivamente dall'undicenne Guido Giolitto di Torino, con 2'9", e dal romano Cadueri, con 3'23", ebbe luogo la prima gara per modelli con motore meccanico, naturalmente solo del tipo ad aria compressa, che venne vinta dal varesino Pietro Masnaghetti, con un volo di 35". Come si vede, ben magri risultati premiavano i concorrenti delle loro notevoli fatiche ... gonfiatorie.

Modello da velocità a due matasse (peso gr. 200, rinvio ad ingranaggi) di Roberto Fedeli, vincitore di un premio speciale al Concorso Nazionale 1932.
Alla stessa gara veniva presentato il primo modello veleggiatore, inteso nel senso moderno cioè il modello trainato col cavo e destinato allo sfruttamento delle termiche. Questa prima costruzione, realizzata dal romano Elvio Tosaroni (ecco un altro nome divenuto famoso), costituì un altro gradino nello sviluppo dell'aeromodellismo; ed infatti già l'anno successivo alla Gara nazionale, assurta alla dignità di primoConcorso Nazionale, si ebbe la categoria veleggiatori, che venne vinta dal torinese Canuto, con un modello leggerissimo che, trovata l'aria calma adatta alle sue possibilità, effettuò un volo di 6'9''.
Gli allievi concorsero con modelli di disegno unico fornito dalla R.U.N.A., e la vittoria fu appannaggio del modenese Bruno Saltini, che segnò 4'43''. Gli anziani invece furono obbligati a presentare modelli del tipo semiriproduzione, e dovettero accontentarsi di risultati più modesti. Infatti risultò vincitore Mirto Tedeschi, di Modena, con 1'48''.
Anche questa gara, però, doveva offrire la sua grande novità. Infatti il bolognese Valerio Ciampolini presentò il primo modello con motore a scoppio, un Brown americano, che se pure finì prematuramente i suoi giorni con una grave scassatura, segnò tuttavia l'inizio di una nuova era per l'aeromodellismo.
Le prime gare per motomodelli
Al Concorso Nazionale del 1936 infatti, era già prevista la prima gara riservata ai motomodelli, ma essa venne abolita all'ultimo momento, essendosi riscontrato il doloso danneggiamento di due modelli concorrenti. Nei veleggiatori, vinse il bolognese Windsor Pederzoli, con 4'24"; mentre i modelli ad elastico presentavano un'altra novità, sia pure di relativa importanza. Infatti alla categoria modelli a tubo vinta dal romano Giacomo Rodorigo con 5'16", venne affiancata quella del modelli "a fusoliera" vinta dal bolognese Giuseppe Rio, con 4'51".
Nel 1937 ebbe finalmente luogo la prima gara per motomodelli, che raccolse 12 concorrenti, e Ciampolini ottenne una meritata affermazione, con un magnifico volo che venne seguito da un aeroplano, della durata di 33', raggiungendo la quota di 1000 m. (la durata del motore era libera). A questa gara apparvero i primi prototipi di motori italiani fra cui un mostruoso "65 cc." presentato dal triestino Fioravante Rizzi, che fortunatamente non riuscì a mettersi in moto, altrimenti chissà quanti guai avrebbe combinato (il modello pesava complessivamente 15 Kg!).
Nello stesso Concorso Nazionale, che raccolse complessivamnete 91 concorrenti, si ebbe la vittoria di Bruno Saltini negli elastico con 4'33" e di Marino bagarini, di Milano, nei veleggiatori, con 4'44"; mentre la categoria "allievi" vedeva la vittoria, con 10'13", del fiorentino Giorgio Bonsi, destinato ad assumere un importantissimo ruolo nell'organizzazione dell'aeromodellismo del dopoguerra.
Ottime affermazioni
Il 1938 si aprì con uno spettacoloso primato per la categoria "veleggiatori", battuto il 6 marzo dal parmense Ennio Morandi con un volo di 1h6'13". Lo stesso anno vide la prima partecipazione italiana ad una gara internazionale, che ebbe luogo a Berna il 22 maggio, in occasione del Congresso dell'I.S.T.U.S. (Comitato Internazionale di Studi per il Volo a Vela). Tale gara, riservata ai modelli veleggiatori in pendio, e comprendente una prova di distanza ed una di durata, raccolse 70 concorrenti di 5 nazioni, fra cui 3 italiani: Morandi, il rimano Mario Rodorigo e l'udinese Franco Bonora, che ottennero un risultato assai lusinghiero, in quanto Rodorigi si piazzò al primo posto nella prova di distanza coprendo 1430 m., ed al terzo posto, con 5'22", in quella di durata, vinta dal tedesco Gunther con 6'21"; mentre Morandi si classificava rispettivamente 12° e 14°.
Il Concorso nazionale, svoltosi sempre a Roma nei giorni 5 e 6 settembre, fu purtroppo avversato dalle cattive condizioni atmosferiche, che provocarono molte scassature, ma non impedirono il conseguimento di buoni risultati. Negli elastico si affermò, con 2'10", il genovese Giulio Pelegi, con un enorme modello a lenta scarica, dipinto nel colore che doveva diventare caratteristico del bravo costruttore: il rosso. Neio veleggiatori, vinse il bolognese Corrado Bertuzzi con 3'14", seguito dal romano Aldo Calza con 2'47".
Gli Allievi concorsero per la prima volta con modelli veleggiatori, e la vittoria toccò al genovese Angelo Tarantino, che effettuò un volo di 12'05". Nei motomodelli la cilindrata del motore era stata opportunamente limitata a 10 cc., e vinse il romano Attilio Obino, che, con un modello costruito da Tosaroni, effettuò un volo di 41'38". Al secondo posto troviamo, con 27'40", quello che doveva divenire "il mago dei motori": Jaures Garofali, detto "Sorino".
Il 1938 si chiuse brillantemente con un altro primato mondiale. Infatti Pelegi, applicati i galleggianti al modello ad elastico vincitore del Concorso nazionale, riuscì a decollare brillantemente dall'acqua ed a volare per 1'30", superando nettamente il precedente primato per gli idromodelli, detenuto da un francese con 49".
Una formula originale
Il 1939 vide un interessante gara svoltasi l'8 giugno a Roma con una formula originale e interessante. Essa infatti fu riservata ai giornali, ognuno dei quali venne abbinato ad un esperto aeromodellista, che costruì e presentò in gara un motomodello. La vittoria toccò al "Popolo" di Trieste, seguito da "Il Piccolo" della stessa città, dal "Giornale d'Italia" e dalla "Gazzetta dello Sport". Complessivamente parteciparono alla gara oltre 20 modelli, la maggior parte dei quali montavano il motore italiano "Giglio", realizzato dall'artigiano fiorentino Grazzini, che sostituì i più costosi motori americani.
La Marcigliana
Il Concorso Nazionale si svolse nei giorni 2 e 3 settembre, e per la prima volta ebbe luogo, anziché all'aeroporto del Littorio, rivelatosi inadatto alle sempre crescenti prestazioni di volo dei modelli, sul campo di volo a vela della Marcigliana. Nei veleggiatori ci fu una novità, consistente nell'introdurre, oltre alla prova in pianura, una in pendio (influenza del Concorso dell'I.S.T.U.S?), che doveva essere effettuata con lo stesso modello, con l'unica facoltà di variarne il peso e la superficie della deriva verticale. Purtroppo tale prova si rivelò deludente per l'infelice località prescelta, il Colle di Castel Giubileo, che provocò la scassatura di molti modelli, e il ... bagno nel Tevere di altri. Tale prova venne vinta dal genovese Rinaldo Burrone con 3'57"; mentre nella prova di pianura si affermava il reggiano Rinaldo Aroldi, il cui veleggiatore, di 3,5 m. di apertura alare (i famosi "tre e cinquanta") sparì in altezza dopo 16'32", e venne ritrovato successivamente a Guidonia, ad oltre 30 Km. di distanza.
Nella categoria "elastico" vinse Ezio Cingolani di Novara, con 4'14", seguito da Pelegi con 4'06". Da notare che la maggior parte dei modelli di questa categoria, compreso il vincitore, avevano abbandonato la lunga scarica ed adottato lo schema della salita veloce, con affinamento delle doti di planata e di sfruttamento delle termiche, secondo gli ultimi dettami della tecnica nei modelli di tipo Wakefield, che venivano seguiti con sempre maggiore interesse (quell'anno la classica gara internazionale venne effettuata in America e vinta dallo statunitense Dick Korda con un volo di 43'29").
Nell'aprile 1940 ebbe luogo a Milano un importante gara interregionale, che nella categoria veleggiatori vide la vittoria del parmense Dino Sirocchi con un volo di 20'6", e negli "elastico" quella del milanese Ermanno Pavesi, che con un grosso modello a lenta scarica segnò 10'2".
Il sesto Concorso Nazionale ebbe luogo ancora alla Marcigliana, e, malgrado lo stato di guerra, segnò un nuovo progresso tecnico e numerico, raccogliendo circa 100 concorrenti. Nella gara per veleggiatori in pianura vinse il romano Alessandro Martorello, con un magnifico volo di 22'09"; mentre quella in pendio, non più effettuata a Castel Giubileo, vide la vittoria di un nuovo elemento che si affacciava alla ribalta, il barese Vincenzo Scardicchio, che segnò 3'20".
Negli "elastico" vinse il triestino Alfredo De Grossi, con 15', seguito dal romano Ercole Arseni con 6'55"; mentre nei motomodelli, con durata di funzionamento limitata a 30", si affermò il milanese Stelio Frati, con 1'39", seguito da Barthel e Grofali, il quale ultimo presentava un motore personale, il primo di una lunga serie.
Singolare ... ritorno a casa
Un'altra importante gara interregionale ebbe luogo alla Marcigliana il 15 giugno 1941 e vide nella categoria veleggiatori la vittoria del genovese Livio De Micheli, con uno spettacolare volo di 22'09". Notevole anche il volo del secondo classificato, il cui modello, scomparso alla vista dopo 12'35", venne successivamente ritrovato nei pressi di Frascati, città dove abitava il costruttore! In questo suo ... ritorno a casa, il modello aveva coperto una distanza di 28 Km. De Micheli completò il suo trionfo con un'altra vittoria negli "elastico" con 2'50"; mentre la categoria motomodelli era appannaggio del romano Fulvio Papalia, con 2'34".
Il Concorso Nazionale di quell'anno ebbe luogo ancora alla Marcigliana, e venne organizzato con un campeggio di tre giorni, al quale intervenirono oltre 250 concorrenti, soddisfattissimi dell'innovazione. La gara dei veleggiatori in pianura fu vinta dal torinese Carlo Ossola, con uno spettacolare volo di 32'15", e quella in pendio da Alberto Alessi, di Cremona, con 6'38".
Nei motomodelli vinse Raffaele Sinopoli di Giudonia, con 15'04", e nei modelli ad elastico si affermò il veneziano Sergio Sabbadin, con un bel volo di 15'15". Da notare che nei modelli ad elastico di allora, malgrado non esistesse alcuna limitazione nel peso della matassa, questa non superava il 30 del peso totale, a causa dell'elevato peso delle strutture, dovuto sia alle difficoltà di reperire il balsa, sia ad un'eccessiva ricerca dell'aerodinamismo, che la tecnica del dopoguerra ha dimostrato essere assai meno redditizia di un aumento della quantità della gomma. Infatti contro i due minuti di media di volo dei modelli del 1941, stanno i 5 - 6 minuti raggiunti nel 1953, prima delle limitazioni imposte dai regolamenti al peso della matassa.
Nuovi motori
Il 1942 portò un'importante novità in campo motoristico: i primi motori ad autoaccensione realizzati in Svizzera. Agli "Etha" seguì l'ottimo "Dyno" che resse validamente il campo per diversi anni. In Italia il motore ad autoaccensione, impropriamente detto "Diesel", si diffuse per merito del patavino Vantini, che nello stesso anno relaizzò i primi prototipi, e quindi, nel 1943, l'ottimo "Antares" da 4 cc.
Quell'anno vi fu una ulteriore innovazione nel Concorso Nazionale, che abbandonò la tradizionale sede di Roma , per essere disputato, sempre sotto forma di campeggio, sull'Altopiano di Asiago, le cui magnifiche condizioni ambientali e meteorologiche ricompensarono ampiamente gli aeromodellisti del lungo e disagiato viaggio. La gara dei veleggiatori in pianura fu vinta da Carlo Ottolini, di Varese, con 35'20", e quella in pendio da Giovanni Prodi, di Reggio Emilia, con 4'59".
I modelli ad elastico sopperirono con le termiche alla difficoltà di trivare della buona gomma, e realizzarono ugualmente ottimi voli. Vinse il milanese Edgardo Ciani, con 27'13", seguito dal concittadino Enea Torrielli, con 12'25". Nei motomodelli si cominciò a notare un ammodernamento della tecnica, con modelli più piccoli ed aventi un maggiore rapporto potenza/peso per aumentare la velocità della salita. Molti usavano gli ultimi motori ad accensione elettrica "Vega 7" da 7 cc., realizzati da già nominato Vantini. Vinse Adriano Bacchetti, di Padova, con 6'13".
La grande novità di quell'anno doveva essere la gara riservata ai modelli autocomandati, che però ottennero risultati assai scarsi. Per la maggior parte si trattava di modelli che montavano un dispositivo ad orologeria, che a mezzo di apposite camme doveva azionare i piani di coda. Questo tipo di comando, soggetto a troppi inconvenienti, non raggiunse mai grande diffusione, e nel dopoguerra venne soppiantato dal radiocomando.Quell'anno il primo premio venne assegnato al forlivese Armando Pagliani.
Un anno di crisi
Il 1943 fu per l'aeromodellismo, come per tutte le attività nazionali, un anno di crisi, e molto difficile fu organizzare il Concorso Nazionale, a causa soprattutto delle difficoltà della comunicazione. Tuttavia all'ultimo momento si riuscì ad effettuare la gara a Firenze, dove venne introdotto per la prima volta il nuovo sistema di classifica a punteggio, che serviva a ridurre l'influenza del fattore fortuna sui risultati. Ricordiamo la vittoria del romano Pagnottelli nella categoria veleggiatori; mentre purtroppo nessuna traccia ci è rimasta degli altri risultati, sommersi nel caos in cui, dopo questa gara, precipitò forzatamente l'aeromodellismo italiano, almeno dal punto di vista organizzativo, perchè gli aeromodellisti, anche fra un allarme aereo e l'altro, trovarono il tempo ed il modo di costruire modelli volanti e di andarli a provare, sfidando bombe e cannonate (e c'è stato anche chi ci ha perso la vita, come il romano Oggioni).
In quel tempo, date le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, prese piede, specie a Roma, la formula dei "65", piccoli e leggerissimi modellini ad elastico, la cui unica limitazione era l'apertura alare stabilita in 65 centimetri, che, con pochi grammi di elastico delle più strane qualità, riuscivano a compiere magnifici voli.
Ci è caro ricordare le numerose gare svoltesi a Roma, con la formula "dividi l'incasso" per ricavare i premi, al campo Parioli, che si doveva raggiungere a piedi, con nelle orecchie il rombo dei cannoni americani che si avvicinavano alla Capitale.
Dopo la tempesta
Passata la bufera iniziò subito la riorganizzazione. Data la forzata inattività dell'Aero Club d'Italia, gli aeromodellisti si organizzarono in gruppi autonomi, che sorsero in tutte le città; e ben presto si cominciò a parlare di una federazione nazionale. Cessato "L'Aquilone", vi furono molte iniziative per creare delle riviste specializzate, alcune delle quali ebbero vita assai effimera, come il "Notiziario Aeromodellistico" a Torino e "L'Aviazione Popolare" a Cremona; mente altre, come "Modellismo" a Roma e "L'Ala" a Firenze riuscirono, sia pure con diverse difficoltà ed irregolarità, a tirare avanti per diversi anni.
Uno dei problemi che furono affrontati per primi fu l'organizzazione di gare che dessero agli aeromodellisti la possibilità di incontrarsi e fare il punto della situazione. Mentre le gare locali non presentavano particolari difficoltà, assai più complicata era l'organizzazione di quelle interregionali e nazionali, date le ingenti difficoltà logistiche e di trasporto. Comunque la passione degli aeromodellisti superò ogni cosa, e già nel 1945 si ebbero le prime competizioni interregionali, che si svolsero con la "formula libera", con le uniche limitazioni di 50 m. per la lunghezza del cavo dei veleggiatori, e di 30 secondi per il funzionamento del motore.
Il 19 agosto una gara a Roma riunì concorrenti romani, napoletani e viterbesi, e vide la vittoria di Renzo Borselli nei veleggiatori, Nicola Petragnani negli "elastico" e Giovanni Ridenti nei motomodelli, tutti romani. Nel settembre dello stesso anno ebbe luogo a Milano il Campionato Alta Italia, che vide il trionfo dei torinesi, vincitori nei veleggiatori con Franco De Benedetti, ideatore della famosa ala A.G.O. dalla caratteristica forma "a scimitarra"; con Igino Maina negli "elastico" e con Franco Muscariello nei motomodelli; mentre nei motomodelli fino a 2 cc. si affermava il milanese Luigi Raggi.
Nell'ottobre, a Firenze, ebbe luogo la prima edizione della Coppa Arno, destinata a diventare una delle "classicissime", che costituì un successo dei milanesi, vincitori con Ciani nei veleggiatori, con Pozzi negli elastico e Cocco nei motomodelli.
Il volo circolare
Il 1946 portò i primi modelli in volo circolare, che offrivano ai giovani la possibilità di pilotare le proprie creature, e nel contempo permettevano di portare l'aeromodellismo nelle piazze cittadine, con grande vantaggio propagandistico, che conferì un notevole impulso quantitativo e qualitativo, malgrado le numerose polemiche suscitate dai puristi appassionati del volo libero.
Numerose furono le gare organizzate in quell'anno, e non ci è possibile soffermarci su tutte. Ricordiamo il "Trofeo Torre Pendente" a Pisa; la "Coppa Modellismo" e il "Trofeo dei Motori" a Roma, che vide la riunione dei rappresentanti regionali e la costituzione della Federazione Aeromodellistica Nazionale Italiana (F.A.N.I.); la Coppa FRAM - l'Ala a Milano e la coppa Arno a Firenze.
Il 1947, oltre all'abolizione della formula libera ed alle prescrizioni relative al carico alare ed alla sezione maestra dei modelli in volo libero, vide l'inizio della corsa alla velocità nel volo circolare. Dopo i primi incerti esordi alla coppa Arno del 1946, alla prima importante gara dell'anno, svoltasi il 16 marzo a Verona, i cosidetti "U-Control" (termine originale americano) raggiunsero i 127 Km orari, per merito del milanese Tacchella.
In quell'anno si ebbe inoltre la prima uscita all'estero degli aeromodellisti italiani nel dopoguerra. Infatti, dopo una selezione effettuata in occasione del Trofeo Quattro Mori a Livorno, una squadra italiana, composta da Valentinis, Cattaneo e Bargelli, con in più i modelli di Crucitti, Nustrini e Mauri per la categoria veleggiatori, e De Micheli, Pecorari e Gnesi, con i modelli di Favillini, Rossi e La Rocca per i motomodelli, partecipò alla gara internazionale di Frauenfeld, in Svizzera, ottenendo i seguenti risultati:
Veleggiatori : Cattaneo primo, Bargelli ottavo, Italia seconda a squadre;
Motomodelli : Pecorari secondo, Gnesi sesto, De Micheli settimo, Italia seconda.
Come si vede un risultato più che lusinghiero, che venne convalidato nello stesso anno da un altro brillante exploit italiano alla Settimana Internazionale di Eaton Bray, in Inghilterra, cui parteciparono a titolo privato Gnesi, il torinese Conte, il cremonese Castellani ed il milanese Clerici, ottenendo tre vittorie con Conte negli elastico formula libera, e Gnesi nei motomodelli e nella velocità, con il modello di Tacchella.
Una vera sagra
Dopo altre gare interregionali, l'annata si chiuse trionfalmente con il X Concorso Nazionale, organizzato dalla F.A.N.I. a Firenze in occasione della Coppa Arno. Fu una vera sagra dell'aeromodellismo, che raccolse oltre cinquecento concorrenti, e pose praticamente fine al disordine del dopoguerra. La gara laureò campioni Van de Velde (un inglese che dimorava a Roma) per la categoria veleggiatori, il pisano Cassola per gli elastico formula F.A.I., il fiorentino Pavanello per i Wakefield, il viterbese Frillici per i motomodelli fino a 3 cc., il cremonese Pitturazzi per quelli fino a 6 cc., e il monfalconese Piccini per i 10cc.; il varesino Taberna per la velocità 3 cc., con 98 Kmh.; il bolognese De Mori per i 6cc. con 112 Kmh. e Tacchella per i 10cc. con 116 Kmh. (notare il rapido progresso in questa categoria). La squadra dell'Aero Club di Pisa conquistò il titolo di Campione Italiano. Furono effettuate anche gare per le categorie modelli da sala, acrobatici e modelli a razzo, che furono vinte rispettivamente dal milanese Cattaneo, da Conte e da Anderle, di Cervignano. Dal punto di vista tecnico da segnalare l'introduzione della doppia matassa, per merito di Cassola.
L'XI Concorso Nazionale
Il 1948 portò un po' di stasi in campo organizzativo, essendosi trasferita la F.A.N.I. da Firenze a Milano, dove non trovò elementi adatti ad assolvere le funzioni. Fortunatamente, in luglio, un deciso colpo di timone portò la Federazione a Roma, e la presidenza venne assunta da Carlo Tione, che si mise prontamente al lavoro di riorganizzazione ed alla preparazione dell'XI Concorso Nazionale.
Come al solito furono disputate numerose gare interregionali, come il Trofeo a Napoli; la prima edizione della Coppa Tevere a Roma, che si differenziava dalle altre gare in quanto il regolamento prevedeva che le successive edizioni si sarebbero svolte nelle località di residenza della squadra vincitrice, e che venne vinta dagli agguerriti monfalconesi, ed altre competizioni.
Il Concorso Nazionale si svolse a Roma dal 3 al 6 ottobre, e vide la vittoria di Bartolomeo Serra di Legnano, nei veleggiatori; del solito Cassola negli elastico; del fiorentino Gino Andrei nei motomodelli; del romano Giovanni Ridenti nelle classi A e B (3 e 6 cc.) della velocità, con 159 e 162 Kmh., e di Kanneworff con un modello di ... Ridenti, nella 10 cc., con soli 127 Kmh. La vittoria a squadre fu conquistata dalla squadra romana. Per il volo circolare fu questo un anno di crisi, perchè spariti dalla circolazione i campioni degli anni precedenti, l'unico elemento veramente valido si dimostrò Ridenti.
La Coppa Wakefield
Molto interesse suscitò in quell'anno la ripresa della classica Coppa Wakefield, che venne disputata in America, essendo stata vinta l'ultima edizione del 1939 dallo statunitense Dick Korda, come già abbiamo ricordato. Vinse l'inglese Chesterton con il suo famoso "Jaguar", che introdusse la tecnica della matassa a treccia inversa lenta, e riportò la Coppa in Europa. Naturalmente l'Italia non potè partecipare, essendo la spesa sproporzionata alle nostre possibilità finanziarie.
Il 1949 si aprì con un'affermazione internazionale conquistata il 23 gennaio a Monaco, in una gara di volo circolare, da Ridenti; e subito dopo si iniziò a parlare della partecipazione italiana alla coppa Wakefield, che si sarebbe svolta in Inghilterra. Dopo alcune preselezioni di zona, la squadra nazionale venne formata in una selezione finale a Firenze il 26 giugno, e risultò così composta: Leardi e Sadorin di Milano, Lustrati e Janni di Roma, Cassola e il trevigiano Cellini. La gara si svolse il 31 luglio sull'aeroporto di Canfield, in pessime condizioni atmosferiche, e vide la vittoria del finlandese Ellila. Il nostro Sadorin si classificò al secondo posto, e gli altri italiani come segue: Cassola 33°, Janni 34°, Lustrati 64°, Leardi 77° e Cellini 87°.
Purtroppo il vento aveva operato una forte falcidia nei nostri modelli, ma l'ottima prestazione di Sadorin era stata sufficiente a tenere alto il prestigio nazionale; tanto più che il giorno successivo, in una gara internazionale di motomodelli, Kanneworf si piazzò al terzo posto.
Fra le gare nazionali da ricordare la seconda edizione della Coppa Tevere che, disputata a Monfalcone, venne riconquistata dalla squadra romana; la prima Coppa Rossi, creata a Milano, per commemorare un aeromodellista scomparso, e destinata a diventare un'altra classica; la Coppa Abruzzi a Pescara; la Coppa Stella d' Italia per i veleggiatori in pendio a Rovereto, ed altre.
Il Concorso Nazionale si svolse a Cremona e vide ottimi risultati tecnici. Nei veleggiatori vinse il livornese Macera; negli elastico Leardi e nei motomodelli il veneziano Battistella, che per la prima volta montò un motore americano da velocità, il Mc Coy 19, montato su un modello da volo libero, le cui velocissime salite stupirono tutti. La vittoria a squadre toccò ancora agli agguerriti romani; mentre la categoria allievi, per la prima volta abbinata al concorso Nazionale, fu vinta dal livornese Di Vecchio.
Sotto l'egida dell'AeCI
Il 1950 vide lo scioglimento della F.A.N.I. ed il passaggio dell'aeromodellismo sotto l'egida dell'Aero Club d'Italia, ormai ritornato in piena efficienza.
Prima gara dell'anno fu la Coppa Tevere che, svoltasi a Roma, vide un'altra vittoria romana. Seguì la Coppa Arno che, dopo una parentesi di due anni, riprendeva il suo posto di "classifica". Quindi a Milano le Giornate Aeromodellistiche Ambrosiane, prima gara internazionale in Italia, riservata al volo circolare, che vide nella classe B la vittoria del veneziano Sabbadin con 137Kmh., e nella C quella dello svizzero Marchon, con 172 Kmh., mentre nella A non si aveva nessun concorrente classificato (come si vede la velocità, ritiratosi anche Ridenti, passato alle corse motociclistiche, era ancora più in crisi). In quell'occasione si ebbe la prima importante gara di acrobazia, che venne vinta da Gnesi.
Nel frattempo iniziarono le preselezioni per la Coppa Wakefield, che culminarono con la finale effettuata a Pisa il 24 giugno. La squadra nazionale risultò composta da Sadorin, Leardi, Kanneworff, Lustrati ed il torinese Fea, che si affacciava prepotentemente alla ribalta dell'elasticismo italiano.
La Wakefield si svolse in Finlandia, nell'incantevole scenario Jamijarvi, sotto la luce crepuscolare della notte nordica. Vinse nuovamente Ellila mentre gli italiani si piazzarono come segue: Leardi terzo, Lustrati settimo, Sadorin nono, Fea venticinquesimo, Kanneworff sessantesimo.
Il XIII Concorso Nazionale si svolse a Bologna dal 12 al 15 ottobre, e vide la vittoria del milanese Piazza nei veleggiatori, la riconferma di Leardi negli elastico e l'affermazione del torinese Padovani nei motomodelli. I milanesi si piazzarono al primo posto a squadre, mentre Gnesi vinceva la gara di acrobazia. In quell'occasione si ebbe la prima esibizione ufficiale di un modello radiocomandato, ad opera dei viterbesi Frillici e Caravello.
Nuove formule di gara
Il 1951 portò sensibili modifiche ai regolamenti di gara. Nei veleggiatori sparirono i "tre e cinquanta" ed i "quattro metri", e venne introdotta la formula A-2, che pose i veleggiatori italiani di fronte a nuovi problemi di progetto. Negli elastico venne unificata la formula Wakefield con quella F.A.I., e venne abolito il rapporto fra la lunghezza della fusoliera e la sezione maestra, il che portò alla nascita dei modelli "lunghi". Nei motomodelli venne limitata la cilindrata del motore a 2,5 cc.e fu istituito il carico minimo di 200 gr./cc.
Prima gara con le nuove formule fu la IV Coppa Tevere, abbinata con la Coppa del Ministero della Difesa Aeronautica, che si svolse a Fiumicino, sul campo del costruendo aeroporto intercontinentale di Roma, e vide la vittoria dell'Aero Club di Treviso nella classifica a squadre, e di Cellini in quella individuale collettiva. Seguirono la Coppa Ostali per idromodelli a Milano, la seconda Coppa Stella d'Italia, la Coppa Aero Club di Genova e altre gare.
La selezione per la coppa Wakefield si svolse ancora a Pisa, e l'onore di rappresentare l'Italia toccò a Leardi, Faiola, Sassola, Lustrati, Pelegi e Sadorin. La gara ebbe luogo nuovamente a Jamijarvi, in conseguenza della vittoria di Ellila dell'anno precedente, e fu vinta dallo svedese Sune Stark. Il nostro Lustrati si piazzò brillantemente al terzo posto seguito da Sassola 10°, Leardi 23°, Pelegi 27°, Sadorin 28° e Faiolo 44°.
Nel settembre ebbe luogo in Olanda un'altra gara internazionale per modelli ad elastico; la Coppa F.N.A., alla quale partecipò la squadra italiana composta dai romani Lustrati, Kanneworff, Faiola e Di Pietro e dai torinesi Fea e Maina. Individualmente vinse lo jugoslavo Fresl ma nella classifica a squadre, che in questa gara era determinante per l'assegnazione della coppa, l'Italia conquistò una brillantissima affermazione, per merito del secondo posto di Lustrati, del terzo di Kanneworff e del sesto di Di Pietro. Maina si piazzò 12°, Fea 18° e Faiola 20°. Il concorso Nazionale si svolse a Milano dal 25 al 28 ottobre, e laureò campioni il pisano Pisani nei veleggiatori, ancora Leardi negli elastico, il genovese Bragaglia nei motomodelli e Gnesi nell'acrobazia. La prevista gara di radiocomando non ebbe praticamente luogo a causa dell'impreparazione dei pochi modelli presentati. La classifica a squadre venne vinta dai pisani.
Nel 1952 numerose furono le gare internazionali cui parteciparono gli aeromodellisti italiani, e due vennero organizzate in Italia. Per prime giunsero le Giornate Ambrosiane, che videro nella classe A (2,5 cc.) la vittoria del veneziano Garlato con 147 Kmh.; nella classe B quella del parigino Millet con 120 Kmh. e nella C quella del veneziano Battistella con 238 Kmh.Questi ultimi due risultati costituivano nuovi primati mondiali. Nell'acrobazia si affermò il milanese Cappi. Come si vede il nuovo anno aveva portato la riscossa dei velocisti italiani, per merito soprattutto dei veneziani.
Subito dopo a Bruxelles lo stesso Battistella si laureava Campione del Mondo per la Classe C, con 233 Kmh.
La Wakefield si svolse a Norrkoping, in Svezia, e malgrado i risultati non fossero proprio disprezzabili, costituì un'altra delusione per i nostri elasticisti che sentivano a ragione di essere ai primi posti nella scala dei valori internazionali, e si vedevano continuamente perseguitati dalla sfortuna. I concorrenti italiani si piazzarono come segue: Lustrati 4°, Kanneworff 6°, Cellini 14°, Piccini 55° e Faiola 56°. L'ambita coppa venne vinta da un altro svedese: Arne Blomgren.
A Graz e a Zurigo
Si ebbe quindi il Campionato Mondiale Veleggiatori a Graz, in Austria, al quale gli italiani parteciparono più che altro a titolo sperimentale, essendo ancora molto inferiori agli stranieri nella nuova formula A-2. Vinse lo jugoslavo Gunic, e noi dovemmo accontentarci del 21° posto di Lustrati, del 25° del monfalconese Boscarol, del 31° del romano Cavaterra e del 35° del milanese Piazza.
Seguì immediatamente il Campionato Mondiale Motomodelli, svoltosi a Zurigo. Vinse l'inglese Wheeler, e noi piazzammo i milanesi Castiglioni e Bergamaschi rispettivamente al terzo e all'ottavo posto, il reggiano Bacchi al 19° e Bragaglia al 33°. Nella classifica a squadre vinse la Svizzera e l' Italia risultò quarta.
La Coppa F.N.A. venne disputata a Fiumicino, e vide la vittoria del torinese Cargnelutti, seguito da Sassola 6°, Lustrati 8°, Sadorin 13°, Pelegi 14° e Kanneworff 17°. Purtroppo la squadra inglese ci portò via la coppa, mentre l'Italia si doveva accontentare del secondo posto a squadre.
Subito dopo sullo stesso campo di Fiumicino ebbe luogo il Concorso Nazionale, che chiuse la stagione sportiva, che aveva già visto lo svolgimento delle solite classiche gare. Nei veleggiatori vinse Cavaterra; negli elastico Fea e nei motomodelli il torinese Cattaneo. Nella classifica a squadre prevalsero ancora una volta i pisani.
Gli Junior
Nel 1953 vennero create le categorie Junior, riservate agli allievi. La stagione internazionale si aprì ancora con le Giornate Ambrosiane, che videro nuovamente un trionfo italiano. Infatti il bolognese Prati vinse la classe A con 162 Kmh. e la B con 204 Kmh.; mentre il solito Battistella, dopo un entusiasmante duello con l'inglese Davenport, vinceva la C con 250 Kmh., battendo nuovamente il primato mondiale. In quell'occasione si ebbe la prima importante gara riservata ai modelli con motore a reazione che venne vinta dal genovese Marcenaro, precursore di questa categoria, con 208 Kmh., nella prova di acrobazia prevalse Cellini.
La coppa Wakefield, a causa della rinuncia della Svezia, venne disputata in Inghilterra, sul solito campo di Cranfield, abbinata con la Coppa F.N.A., riservata alla classifica a squadre; contemporaneamente ebbe luogo il Campionato Motomodelli. La grande manifestazione vide un trionfo degli americani che vinsero ambedue le categorie sia a squadre che individualmente, per merito di Foster (elastico) e Kneeland (motomodelli). Gli italiani dovettero accontentarsi dei seguenti piazzamenti:
- nella Coppa Wakefield Kanneworff 9°, Fea 11°, lo spoletino Noceti 20°, Sadorin 26° e la squadra quarta;
- nei motomodelli il milanese Vidossich 3°, Bacchi 16°, il torinese Marchina 23°, Bergamaschi 29° e la squadra terza. Il Campionato mondiale veleggiatori si svolse a Lesce Bled in Jugoslavia, e mostrò ancora l'inferiorità italiana in questa categoria. Il primo nostro concorrente fu il romano Federici, ottavo; quindi il fiorentino Lensi 23°, Pisani 31° e il ravennate Toni 35°. La squadra risultò ottava. Il danese Hansen vinse individualmente e contribuì al successo collettivo della sua squadra.
Modifiche e riduzioni
Il XVI Concorso Nazionale ebbe luogo a Reggio Emilia, e vide la vittoria del torinese Lusso nei veleggiatori, del veneziano Murari negli elastico, di Bacchi nei motomodelli, del bolognese Caprora nei veleggiatori junior, del romano Ricci negli elastico junior e del ferrarese Squagliella nei motomodelli junior, dell' Aero Club di Reggio Emilia nelle squadre senior e di quello di Torino nelle junior. In quell'occasione ebbe luogo un'esibizione di modelli radiocomandati, che fu dominata dalla genovese Capecchi-Ferrari.
Nel 1954 si ebbe la prima restrizione della matassa elastica, il cui peso venne limitato ad ottanta grammi. Scomparvero così dalla scena i doppia matassa, e le prestazioni di volo si ridussero sensibilmente. Contemporaneamente il cavo di lancio dei veleggiatori venne ridotto da cento a cinquanta metri; mentre per i motomodelli veniva diminuita la durata di funzionamento del motore da venti a quindici secondi. La sezione maestra minima venne abolita, ed il tempo massimo di volo fu ridotto, per tutte le categorie, da cinque a tre minuti.
In quell'anno gli aeromodellisti italiani dovettero accontentarsi della partecipazione al Campionato Mondiale Veleggiatori, che si svolse ad Odense in Danimarca, in pessime condizioni atmosferiche, e vide la vittoria del tedesco Lindner. Fra gli italiani il migliore fu Nironi, che si classificò quarto, mentre Jotti dovette accontentarsi del trentottesimo posto, Boscarol del quarantatreesimo e Federici del cinquantaquattresimo. L'Italia si piazzò al nono posto nella classifica per nazioni, capeggiata dalla Germania.
La Coppa Wakefield ed il Campionato Motomodelli si svolsero contemporaneamente negli Stati Uniti, e vennero vinti rispettivamente dall'australiano King e dall'americano Wheeley; mentre gli Stati Uniti si aggiudicavano nuovamente ambedue le vittorie a squadre.
Naturalmente era mancata la partecipazione italiana, non essendosi potuti reperire gli ingenti fondi necessari per il lungo viaggio. L'attività nazionale, oltre alle consuete gare, vide l'annuale edizione delle Giornate Ambrosiane, che però non raccolsero concorrenti esteri, a causa della concomitanza con il Criterium d'Europa a Bruxelles, e si svolsero in tono alquanto minore. La manifestazione si risollevò in chiusura con una spettacolare prestazione del bolognese Prati, che conquistò il nuovo record mondiale di velocità per la classe A con 190 Kmh. Il Concorso Nazionale 1954 ebbe luogo a Milano e laureò i seguenti campioni: il monfalconese Boscarol per i veleggiatori, il reggiano Pietralunga per gli elastico, il suo concittadino Bacchi per i motomodelli, il romano Cova per i veleggiatori junior ed i bolognesi Monti e Zapata rispettivamente per gli elastico e motomodelli junior. L'Aero Club di Milano vinse la classifica a squadre senior e quello di Bologna quella junior. Venne effettuata anche una gara di modelli radiocomandati, vinta dal romano Mazzolini, ed una per modelli "PAA-Load", motomodelli con carico addizionale, indetta dalla Pan American Airways, che venne vinta da Cellini.
La Coppa Capriolo
Il 1955 vide, oltre alle consuete gare, la prima edizione di un'altra "classica": la Coppa Capriolo a Salerno, nata per commemorare un aeromodellista salernitano perito nell'alluvione del 1954, e organizzata dal delegato Libertino con una formula nuova, che accoppia il turismo allo sport.
Da quell'anno il Campionato Mondiale di velocità venne riservato ai modelli della classe A, e si svolse a Parigi, con un vero trionfo italiano. Infatti i nostri rappresentanti conquistarono il primo posto a squadre, ed il secondo, terzo, quarto e quinto posto, rispettivamente con Prati, Monti, Cappi e Gottarelli, nella classifica individuale, vinta dal cecoslovacco Sladky con 179 Kmh. Tutti i nostri concorrenti usavano i motori supertigre G.20, che da allora saranno praticamente gli unici usati in Italia per la velocità in classe A.
Il successo di Wiesbaden
Per quanto riguarda i Campionati di volo libero, gli americani, per venire incontro agli aeromodellisti del vecchio continente, organizzarono le tre categorie contemporaneamente sulla base aerea di Wiesbaden, in Germania. Gli italiani parteciparono al gran completo ed ottennero ottimi risultati. Infatti nella categoria veleggiatori, vinta nuovamente da Lindner, il nostro Giusti si piazzò quarto, Varetto dodicesimo, Boscarol ventinovesimo, Nironi trentaseiesimo e la squadra risultò prima.
La categoria elastico culminò con uno spareggio a sette, fra cui i nostri Scardicchio e Fea, vinto dal tedesco Samann. Prandini risultò ventinovesimo e Pietralunga trentacinquesimo, mentre la squadra si classificava terza, dopo Svezia e Germania. Nei motomodelli vinse l'inglese Gaster, ed il nostro uomo, Vidossich, dovette accontentarsi del settimo posto, seguito dal decimo di Podda, dal quattordicesimo di Bacchi e dal quarantasettesimo di Bergamaschi. La squadra italiana si piazzò seconda dopo l'Inghilterra.
Da quell'anno ebbe inizio l'assegnazione dei titoli nazionali anche per le diverse categorie del volo circolare, prendendo per validi i risultati della seconda edizione della Coppa Shell a Genova. Nella classe A, vinse il bolognese Monti, con 176 Kmh.; nella B, il milanese Cappi, con 240 Kmh.; nella C, il bolognese Prati, con 229 Kmh. e nella D (reattori) il genovese Podda, con 210 Kmh. Lo stesso Cappi vinse la gara di acrobazia, mentre il trentino Di Bello vinceva la prima gara nazionale di Team-Racing, con il tempo di 8'.
Il Concorso Nazionale di volo libero invece ebbe luogo a Viterbo, e vide la vittoria del barese Schino nei veleggiatori senior, del reggiano Mescoli in quelli junior; di Fea negli elastico senior e del suo concittadino Pontiglio negli junior; del reggiano Baracchi nei motomodelli senior e del milanese Volpi negli junior. Nella classifica a squadre senior si affermò l'Aero Club di Bologna, e nella junior quello di Milano.
Anche nel 1965 numerosissime furono le gare svoltesi con successo. Il 20 maggio il romano Marconi riconquistò all'Italia il primato mondiale di velocità, già strappato dall'inglese Gibbs al nostro Prati, segnando 215 Kmh.
Un po' di sfortuna
Il primo Campionato mondiale fu quello riservato ai Motomodelli, che ebbe luogo sull'ormai noto campo di Cranfield, in Inghilterra. Vinse l'inglese Draper, e gli italiani ottennero il quinto posto con Bergamaschi, il quarantesimo con Zappata, il quarantacinquesimo con Monti, il cinquantunesimo con Bacchi, e solo il dodicesimo nella classifica a squadre. Come si vede risultato avverso, dovuto un po' alla pioggia ed un po' alla sfortuna, perchè i nostri modelli erano tutti buoni.
Subito dopo ebbe luogo a Hoganas la Coppa Wakefield, che fu anch'essa avversata dalle condizioni atmosferiche. Infatti alla pioggia si aggiunse il forte vento, e la nostra squadra incappò in un'altra giornata sfortunata. Il nostro Fea, che era in testa al quarto lancio, dovette rinunciare al quinto, avendo perduto ambedue i modelli, finendo così ventesimo. Il nostro migliore uomo fu Scardicchio quattordicesimo, mentre Alinari e Cassi si piazzavano rispettivamente diciottesimo e ventisettesimo. Vinse lo svedese Petersson, e la Svezia si aggiudicò anche il primo posto a squadre, mentre l'Italia si classificava quinta. Alla gara partecipò, per la prima volta, la squadra russa, che si piazzò al secondo posto.
In settembre furono disputati a Firenze i Campionati Mondiali Veleggiatori e Velocità, che ci portarono purtroppo altre delusioni, malgrado fossimo in casa nostra, in forza della vittoria dell'anno precedente. Infatti nella velocità vinse, con 211 Kmh., l'inglese Gibbs, che fuori gara battè anche il primato di Marconi, portandolo a 225 Kmh. Il migliore italiano fu Cellini, terzo con 200 Kmh., mentre Prati si classificava ottavo. Berselli quattordicesimo e Monti quindicesimo. L'Italia era seconda dopo la Cecoslovacchia.
Nei veleggiatori, dopo una giornata magnifica, ma purtroppo piena di termiche e discendenze, vinse il belga Brems, con un modello di concezione molto antiquata. Il nostro Giusti si piazzò ventiduesimo, Posa trentanovesimo, Nironi quarantaduesimo e Caprara cinquantaquattresimo. La squadra italiana finì nientemeno che al tredicesimo posto, mentre quella cecoslovacca si aggiudicò anche questa categoria.
Piccola... rivoluzione
Il Concorso Nazionale ebbe luogo in stagione molto inoltrata a Capua, e malgrado il maltempo riuscì a svolgersi abbastanza regolarmente. Vinsero il bolognese Possenti nei veleggiatori senior, Scardicchio negli elastico, il milanese Piazzoli nei motomodelli, il monfalconese Cragnolin nei veleggiatori e negli elastico junior, ed il suo concittadino Zampar nei motomodelli. Torino vinse la classifica a squadre senior, e naturalmente Monfalcone quella junior, mentre la gara di radiocomando era appannaggio di Pelegi.
Fra la fine del 1956 ed i primi del 1957 si ebbe una piccola rivoluzione organizzativa, che portò alle dimissioni del signor Tione da presidente della Commissione per l'Aeromodellismo dell'AeCI ed alla elaborazione di una regolamentazione per l'attività aeromodellistica, che prevede l'organizzazione di un Congresso nazionale e le libere elezioni dei membri della Commissione. Guglielmo Barthel venne eletto in sostituzione di Tione, nel posto che tuttora occupa.
Venne inoltre decisa la trasformazione del Campionato Italiano da prova unica a prove multiple. Per il 1957 furono valevoli per il volo libero la Coppa Rossi, la Coppa Bertocco (che aveva sostituito la Coppa Tevere), la Coppa Arno, la Coppa Laganà a Reggio Calabria e la Coppa Reno a Bologna; per il volo circolare la Coppa Supertigre, la coppa Shell, le Giornate Ambrosiane e la Coppa della Madonnina a Milano.
Il Campionato di volo libero si chiuse pertanto a Bologna, e laureò Campioni i bolognesi Possenti e Negri, rispettivamente per i veleggoatori e gli elastico senior; il varesino Mantovani per i motomodelli; altri due bolognesi, Poluzzi e Volta, per i veleggiatori ed elastico junior; il milanese Bonini nei motomodelli junior; l'Aero Club di Varese nelle squadre senior e quello di Bologna nelle junior. In occasione della Coppa Reno ebbe luogo anche il Concorso Nazionale per modelli radiocomandati, in prova unica, che venne vinto dal romano Mazzolini.
La Coppa Shell chiuse invece il Campionato di volo circolare, che vide le affermazioni del veneziano Grandesso nella I serie (ex classe A) con 202 Kmh.(prova migliore ottenuta durante le varie gare); del bolognese Tampellini nella II serie (ex classe B) con 214 Kmh.; del milanese Berti nella III serie (ex classe C) con 250 Kmh.; del trevisano Zanin, ottimo costruttore di reattori, nella IV serie, con 233 Kmh. e della coppia torinese Appiano-Ravera nel Team-Racing.
Nuova vittoria orientale
Quell'anno i Campionati Mondiali ebbero luogo per le sole categorie veleggiatori e velocità. Le due gare si svolsero a Praga e videro un'altra netta affermazione degli aeromodellisti delle nazioni orientali. Infatti lo jugoslavo Babic vinse la categoria veleggiatori, mentre a squadre si affermava la Russia. Fra gli italiani il migliore risultò Medaglia, nono, seguito da Varetto, diciannovesimo. Possenti cinquantesimo e Schirru sessantottesimo. La nostra squadra si classificò al settimo posto.
Nella velocità altro trionfo della cecoslovacchia, che conquistò il primo posto a squadre ed i primi tre individuali, con Sladky, Zatocil, Pastjrik. Noi ci dovemmo contentare del sesto posto di Grandesso, dell'ottavo di Prati e del nono di Berselli, mentre Cellini non riuscì a classificarsi. La nostra squadra risultò seconda.
Un buon successo riscosse un'altra gara svoltasi in Italia, e cioè la Coppa Stella d'Italia per veleggiatori in pendio a Rovereto, che andava sempre più accentuando il suo carattere internazionale. Vinse il bavarese Wensauer, seguito dal nostro Cobelli. Questa gara segnò il trionfo del direzionale magnetico sui modelli in pendio.
Il 1958 si aprì con un nuovo cambiamento di formula. Mentre restavano invariati i veleggiatori, nei modelli ad elastico la matassa veniva nuovamente ridotta da 80 a 50 gr.; nei motomodelli il carico per cilindrata veniva elevato da 200 a 300 g/cc., e quello superficiale da 12 a 20 g/dmq. Per i modelli da velocità della I serie veniva imposta una superficie di 2 dmq/cc.; e nei Team-Racing veniva stabilita una superficie di 12 dmq.
Per il Campionato nazionale di volo libero vennero considerate valide la Coppa Rossi, la Coppa Bertocco, abbinata alla Coppa Bonmartini, che riprendeva il suo ruolo; la Coppa Arno, il Premio Etneo, la Coppa Laganà e la Coppa Reno. Per la velocità ed il Team-Racing le Giornate Ambrosiane, la Coppa Supertigre, e la Coppa Shell. Per il radiocomando la Coppa Bonmartini, la Coppa Reno e la Coppa Radiovittoria, nuova gara romana. Per l'acrobazia l'unica prova della Coppa Città della Madonnina.
Un brillante successo venne ottenuto in una gara internazionale di idromodelli a Monaco da Fea per la categoria elastico e da Piazzoli per i motomodelli, i quali bissavano il successo già ottenuto l'anno precedente nella stessa gara.
Dopo la Coppa Città della Madonnina si ebbe già il primo campione Italiano: il milanese Bellasi, vincitore della gara di acrobazia.
Buoni risultati italiani
A Cranfield ebbero luogo i Campionati Mondiali per elastico e motomodelli, con risultati per noi discreti. Infatti nella Coppa Wakefield, vinta dall'australiano Baker, il nostro Scardicchio si classificò quarto, Fea settimo, Licen trentunesimo e Taberna cinquantaquattresimo. La nostra squadra risultò seconda dopo l'Ungheria. Nei motomodelli vinse l'ungherese Frigyes, ed ancora l'Ungheria si piazzò prima a squadre. Dei nostri, Simonetta fu ottavo, Pecorari diciasettesimo, Castegnaro ventottesimo e Piazzoli cinquantaduesimo. La squadra italiana risultò quarta.
Si ebbero quindi a Bruxelles i Campionati di volo circolare. Nella velocità, vinta dall'ungherese Beck, la nostra squadra, composta dai bresciani Rossi Cesare, Rossi Ugo e Pezzi, che si erano prepotentemente affacciati alla ribalta della velocità, e dal solito Prati, si piazzò al terzo posto, con i rispettivi sesto, settimo, nono e decimo posto individuale. L'Ungheria vinse anche la classifica a squadre.
Nella prova di acrobazia, per la prima volta elevata al rango di Campionato del Mondo, insieme a quella di Team-Racing, vinse il cecoslovacco Gabris, ed il nostro Bellasi risultò quattordicesimo, seguito da Pezzini venticinquesimo e Fabio Contini ventisettesimo. A squadre vinse la solita Ungheria, e l'Italia fu nona. Nel Team-Racing il modello inglese di Edmonds superò di poco quello italiano di Taddei. Gli altri italiani si piazzarono come segue: Ugo Rossi settimo, Fabio Ontini ottavo e Cesare Rossi sedicesimo.
Terminate le prove di Campionato Italiano, i titoli vennero assegnati a Medaglia per i veleggiatori senior, ancora a Poluzzi per gli junior; a Fea per gli elastico senior e al suo allievo Schirru per quelli junior; a Piazzoli per i motomodelli senior ed al suo concittadino Reverdy per gli junior; alla FIAT di Torino per le squadre senior e junior; al romano Saguto per il radiocomando; a Ugo Rossi per la velocità I serie, con 209 Kmh., e per la II serie con 235 Kmh.; a Grandesso per la III serie, con 246 kmh., e a Zanin per la IV serie, con 251 Kmh.
Il 1959
E così, passo passo, siamo arrivati al presente. Il 1959 ha visto l'istituzione del titolo di Campione Italiano anche per gli idromodelli ad elastico ed a motore, le giurie fisse per le gare di radiocomando e di acrobazia in volo circolare, che assicurano uniformità di punteggio, e le prime piste dedicate esclusivamente al volo circolare, costruite con il contributo dell' Aero Club d'Italia.
Il Campionato di volo libero si è svolto su sei prove: la Coppa U.T.A. a Torino, la Coppa Rossi, la Coppa Ballestra a Bari, la Coppa Arno, la Coppa Bonmartini ed il trofeo Etneo.
Hanno vinto il varesino Bulgheroni nei veleggiatori senior, il suo concittadino Taberna negli elastico ed il monfalconese Parovel nei motomodelli; i fiorentini Bulli e Papi nei veleggiatori ed elastico junior ed il bolognese Dapporto nei motomodelli. Ancora la FIAT di Torino fra le squadre senior e quella del G.A.P. Firenze fra le junior.
Nel radiocomando, dopo la Coppa Radiovittoria, la Coppa Rossi e la Coppa Bonmartini, sono stati dichiarati campioni Gnesi per il monocomando ed il romano Cassinis per il pluricomando (da quest'anno le due categorie vengono effettuate separatamente). Per gli idromodelli sono state effettuate la Coppa Lago di Varese, la Coppa Kalb a Salerno e la Coppa Ostail a Milano. Si sono laureati campioni il milanese Pelizza per gli elastico ed il varesino Medaglia per i motomodelli.
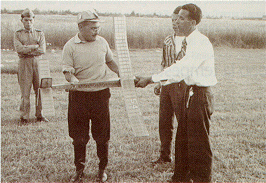
Il milanese Sadorin (secondo classificato alla Coppa Wakefield del 1949) ed il torinese Fea, due dei migliori elasticisti italiani, ripresi insieme a Firenze nel 1956
Due Campionati Mondiali sono stati disputati quest'anno. La Coppa Wakefield, in Francia, è stata vinta dal cecoslovacco Dvorak, e gli italiani hanno ottenuto i seguenti piazzamenti: Fea, tredicesimo, Taberna, trentunesimo e Scardicchio trentaquattresimo ( le squadre nazionali sono state ridotte a tre elementi). La squadra statunitense si è piazzata al primo posto, mentre quella italiana è risultata quinta.
Il Campionato Veleggiatori in Belgio ha visto la vittoria dello statunitense Ritz, mentre a squadre ha vinto la Finlandia. Degli italiani, Bulgheroni si è classificato ottavo, Taberna quindicesimo e Soave ventottesimo. La nostra squadra si è piazzata al quarto posto.
La Coppa Stella d'Italia in pendio a Rovereto ha visto ancora la vittoria di un tedesco: Friedrich, mentre primo degli italiani è stato il vicentino Marangoni, terzo. Maggiori sodddisfazioni ci ha dato il Criterium d'Europa di volo circolare, nel quale il nostro Ugo Rossi ha vinto la categoria velocità con 222 Kmh., mentre il fratello Cesare si classificava terzo con 210 Kmh. Nel Team-Racing abbiamo avuto il sesto posto dei fratelli Contini, l'ottavo dei Rossi e il tredicesimo di Berselli. Nell'acrobazia, Campostella si è classificato nono, Marco Contini decimo ed il fratello Fabio tredicesimo. L'Italia si è piazzata seconda a squadre nell'acrobazia, terza nel Team-Racing e quarta nella velocità, dove solo la sfortuna che ha perseguitato il nostro Prati, impedendogli di fare un solo,lancio valido, ci ha tolto una brillante vittoria.
Alla Coppa Re dei Belgi di radiocomando in Germania, vinta dallo svizzero Bickel, il nostro unico concorrente Corghi si è classificato al sesto posto nella categoria pluricomando.
Il formidabile Rossi
Ultimi a concludersi sono stati i Campionati nazionali di volo circolare. Quello di acrobazia, disputato con la Coppa Città della Madonnina, la giornata dell'Ala Minima ad Ivrea ed il Trofeo Città di Torino, ha laureato campione il torinese Lavazza; mentre il Campionato di velocità e Team-Racing è stato chiuso dalle Giornate Ambrosiane, svoltesi l'8 novembre a Milano, a coronamento delle precedenti Coppa Supertigre, Coppa Shell e Coppa Celeste Patrona Aeronauti a Loreto. Il formidabile Ugo Rossi ha conquistato tutti i titoli della velocità, con 219 Km nella I serie, 233 nella II, 246 nella III e 255 nella IV e la coppia bolognese Berselli-Monti ha conquistato il titolo nel Team- Racing, con 120 Kmh.
Chiuso così anche il 1959, gli sguardi già si volgono al futuro, al continuo progresso in atto, ed alla speranza di risultati sempre migliori. Cosa ci riservino i prossimi anni non è possibile dire. Sempre più trionfale la marcia al radiocomando, che malgrado le sue notevoli difficoltà tecniche ed economiche, offre già notevoli possibilità agli aeromodellisti, ed è suscettibile di affascinanti sviluppi per il futuro. Quasi certamente in esso sta l'avvenire dei modelli volanti che, liberati dalla schiavitù dei vasti campi di gara, sempre più difficili da reperire, potranno compiere i loro voli e le loro evoluzioni sui campi sportivi, alla presenza di un pubblico che ci auguriamo sempre più numeroso ed appassionato, in modo da incrementare quell'opera di propaganda aeronautica che è uno degli scopi fondamentali dell'aeromodellismo.